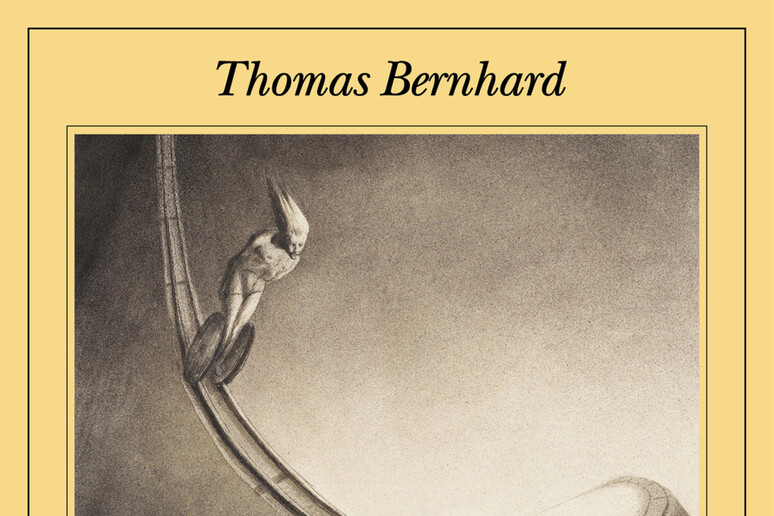
Un mosaico di ossessioni: il ritorno di ‘Correzione’
George Steiner definì ‘Correzione’ il capolavoro di Thomas Bernhard, un’affermazione che risuona vera per chiunque si sia immerso nel mondo dello scrittore austriaco. Ogni sua opera, che sia narrativa, poetica o teatrale, sembra essere una tessera di un unico, immenso mosaico, un capitolo di un’opera-mondo in cui temi e situazioni ricorrono ossessivamente, sublimemente. ‘Correzione’, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1975 e ora riproposto da Adelphi con la traduzione di Giovanna Agabio, non fa eccezione. Qui, come in altre opere, ci si addentra nel ‘fil rouge’ delle ossessioni bernhardiane, un ‘gnommero’ gaddiano che avviluppa mente e membra.
Roithamer e il cono utopistico: un’allegoria del genio
Lo stile inconfondibile di Bernhard, con la sua rarità di punti e la sua prosa avvolgente, ci trascina nella vicenda di Roithamer e della sua soffitta, un luogo pieno di formule e libri. La voce narrante, amico d’infanzia e professore di matematica a Cambridge, è incaricata di gestire le opere postume di questo genio folle. Roithamer aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita a costruire, con metodi misteriosi e senza l’aiuto di architetti, un cono utopistico nel cuore di un bosco, investendo tutta la sua eredità. Questo cono era destinato alla sorella, ma la sua morte prematura lascia Roithamer senza ragioni per vivere, spingendolo al suicidio.
Suicidio, Austria e scuola: i temi ricorrenti di Bernhard
Il suicidio, tema centrale nell’opera di Bernhard, ritorna anche in ‘Correzione’. Allo stesso modo, riemergono i sentimenti contrastanti verso l’Austria, un paese amato per le sue origini ma odiato per le ‘bastonate’ ricevute. Anche la scuola, percepita come luogo di depressione e umiliazione, è un tema ricorrente. Ma il fulcro di ‘Correzione’ è il confronto con il genio. La voce narrante si interroga sull’ordine di grandezza di Roithamer, un personaggio che sembra ispirato a Ludwig Wittgenstein, anch’egli legato alla sorella e docente a Cambridge.
Il dilemma del ‘soccombente’: aspirazione e tormento
Come ne ‘Il soccombente’, ispirato a Glenn Gould, ‘Correzione’ esplora il dilemma di chi pratica una disciplina con eccellenti risultati, ma si rende conto di non poter raggiungere il genio. Questo genera un’infinita aspirazione, un desiderio di seguire le orme del genio, pur comprendendone e ammirandone la grandezza. Anche in ‘Correzione’ la musica ha un ruolo fondamentale: Roithamer ama la musica, suona il pianoforte e la considera uno strumento di conoscenza.
La ‘Correzione’ come essenza del genio
La ‘Correzione’ del titolo rappresenta l’essenza del genio: il tendere a una perfezione che consiste in una continua revisione. Bernhard è interessato all’estremo, alla ricerca spasmodica, ai personaggi portati al limite. Spinge il lettore in una spirale di ripetitività ipnotica, sull’orlo di un abisso dove l’assoluto incontra il nulla. Il suo stile, con la sua parsimonia di punti, riflette la difficoltà di concludere un pensiero, di ingabbiare una frase in un ritmo logico. Alla fine, la natura avviluppa tutto, compiendo il suo corso.
Un’eredità letteraria senza tempo
‘Correzione’ è un’opera complessa e stratificata, che richiede un’immersione totale nel mondo di Thomas Bernhard. La ripubblicazione di Adelphi offre una nuova opportunità per confrontarsi con uno dei più grandi scrittori del Novecento, un autore capace di scavare nell’animo umano con una profondità e una lucidità disarmanti. La sua ossessione per il genio, il suicidio, l’Austria e la scuola si traducono in una prosa ipnotica e destabilizzante, che non lascia indifferenti.







