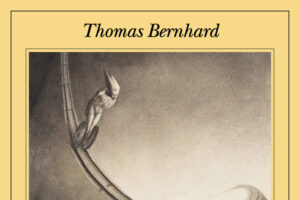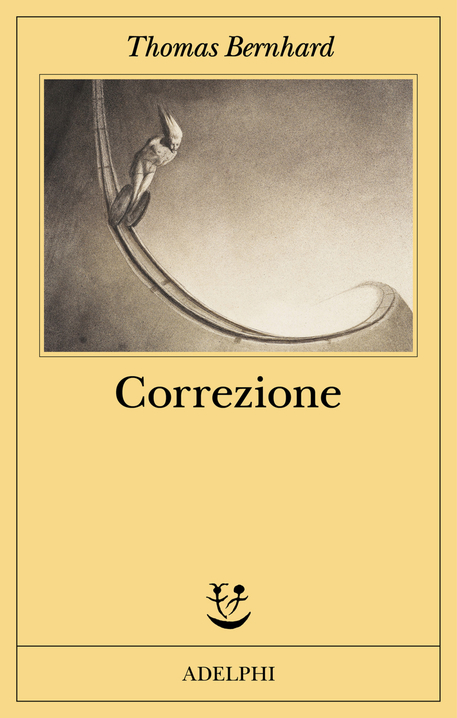
Un capolavoro nel mosaico bernhardiano
George Steiner definì ‘Correzione’ il capolavoro di Thomas Bernhard, un’affermazione che, per chi conosce l’opera dello scrittore austriaco, non suona affatto azzardata. Ogni sua opera, narrativa, poetica o teatrale, è una tessera di un mosaico complesso, un capitolo di un’opera mondo in cui temi e situazioni ricorrono ossessivamente, raggiungendo vette di sublime intensità. In questo romanzo, pubblicato originariamente nel 1975 e ora riproposto da Adelphi con la traduzione di Giovanna Agabio, ci si immerge nel ‘fil rouge’ delle ossessioni bernhardiane, un labirinto gaddiano di pensieri e sentimenti.
Roithamer e la soffitta: un universo di formule e libri
Lo stile inconfondibile di Bernhard, caratterizzato da periodi lunghi e complessi, avvolge il lettore nella vicenda di Roithamer e della sua soffitta (in realtà di Holler), un luogo denso di formule e scaffali di libri. La voce narrante, amico d’infanzia e professore di matematica a Cambridge, è incaricata di gestire le opere postume di questo genio folle. Roithamer aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita alla costruzione di un cono utopistico nel cuore di un bosco, un progetto ambizioso realizzato in tempi record e con metodi misteriosi, senza l’ausilio di architetti, e finanziato con l’eredità ricevuta. Il cono era destinato alla sorella, la cui prematura scomparsa aveva privato Roithamer di ogni ragione di vita, spingendolo al suicidio.
Suicidio, Austria e scuola: i temi ricorrenti
Il suicidio, tema ricorrente nell’opera di Bernhard, si affianca ai sentimenti contrastanti verso l’Austria, terra d’origine amata e odiata per le sofferenze inflitte. Anche la scuola, vissuta come luogo di depressione e umiliazione, è un tema centrale. Ma il cuore del romanzo è il confronto con il genio, l’interrogativo sulla propria statura intellettuale di fronte alla grandezza di Roithamer. Il personaggio di Roithamer sembra ispirato a Ludwig Wittgenstein, filosofo legato alla sorella e docente a Cambridge. Come ne ‘Il soccombente’, ispirato a Glenn Gould, si esplora il dilemma di chi, pur eccellendo in una disciplina, non potrà mai raggiungere il livello del genio, che ammira e comprende profondamente.
Musica e correzione: l’essenza del genio
L’amore per la musica, un altro elemento chiave nell’opera di Bernhard, emerge anche in ‘Correzione’. Roithamer suona il pianoforte e considera la musica uno strumento di conoscenza. La ‘correzione’ del titolo rappresenta l’essenza del genio, la ricerca di una perfezione che si concretizza in un continuo processo di revisione. Bernhard si spinge all’estremo, conducendo il lettore in una spirale di ripetitività ipnotica, sul limite di un abisso in cui l’assoluto incontra il nulla. L’uso parco dei punti riflette la difficoltà di concludere un pensiero, di ingabbiare una frase in un ritmo logico.
La natura e il suo corso
Alla fine, la natura, avviluppando ogni cosa, farà il suo corso, riportando tutto a un equilibrio precario e in costante mutamento. ‘Correzione’ è un’opera che sfida il lettore, lo costringe a confrontarsi con le proprie ossessioni e con l’abisso dell’esistenza, offrendo una riflessione profonda sulla natura del genio e sulla ricerca della perfezione.
Un’immersione nell’abisso dell’esistenza
‘Correzione’ di Thomas Bernhard è un’opera complessa e stratificata, che richiede un’immersione totale nel suo universo ossessivo. La prosa ipnotica e ripetitiva, la profondità dei temi trattati e la complessità dei personaggi rendono la lettura impegnativa, ma al contempo estremamente gratificante. Bernhard ci invita a confrontarci con le nostre paure, le nostre ossessioni e la nostra aspirazione all’assoluto, offrendoci uno sguardo impietoso e al contempo profondamente umano sulla condizione umana.